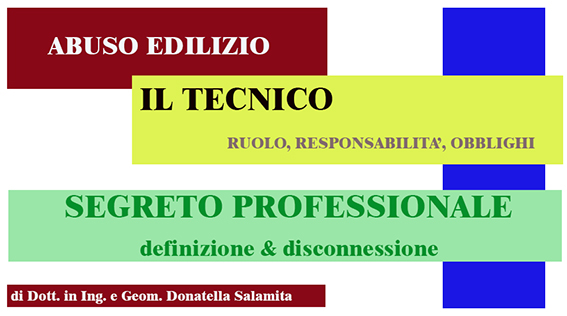Il tecnico e l’edilizia privata: responsabilità, abusi edilizi ed obbligo di denuncia agli enti, non vi è correlazione alcuna con il segreto professionale
1) Il professionista che, incaricato dal privato per la progettazione di una ristrutturazione, come agisce nel caso in cui rilevi difformità edilizie nell’immobile?
2) Il ruolo del tecnico - progettista
3) La prassi corretta laddove il committente crei insistenze per il completamento della prestazione professionale
4) Trattazione di un caso pratico: “il committente si rivale sul tecnico – progettista per non aver inteso presentare progetto di ristrutturazione per l’immobile nel quale presenti abusi edilizi”
5) L’azione immediata del professionista
6) Il segreto professionale: oggetto e complemento
7) Il segreto professionale al cospetto di ciò che attiene un immobile
8) La Fondazione Italiana del Notariato
1) Il professionista che, incaricato dal privato per la progettazione di una ristrutturazione, come agisce nel caso in cui rilevi difformità edilizie nell’immobile?
Preliminarmente il tecnico rende edotta la committenza circa lo stato di fatto dell’immobile, e, nel consigliare la regolarizzazione dell’abuso, ne effettua la valutazione, in primis se trattasi di “tolleranze costruttive” ai sensi dell’art.34 del D.p.r. 380/2001, quindi, se non soddisfatta la verifica, classificando le opere eseguite nel rispettivo regime abilitativo secondo i disposti del medesimo Testo Unico per l’Edilizia, si avranno, pertanto tre ipotesi di “sanatoria”:
- comunicazione di inizio lavori asseverata, C.I.L.A., ai sensi dell’art.6-bis, comma 5, con versamento della sanzione di euro mille, se trattasi di opere che non abbiano interessato le parti strutturali dell’edificio, ovvero rientranti nell’attività edilizia libera;
- permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art.36, se trattasi di interventi eseguiti in assenza o difformità dal medesimo titolo abilitativo edilizio o dalla S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire;
- segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, ai sensi dell’art.37 se trattasi di interventi realizzati in sua assenza o difformità.
Le opere da “sanare” dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso e sia al momento della presentazione dell’istanza per l’ottenimento del permesso di costruire o della trasmissione della S.C.I.A.
Nulla esclude il committente rifiuti di sanare le opere, talora anche elevando nei confronti del professionista pretese non legittime, in questo caso la figura del tecnico coincide con quella del progettista?
In considerazione del fattore si stia trattando una fase tecnica priva di trasmissione del progetto allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune ove ricade l’immobile, nulla muta in relazione al ruolo del tecnico, la cui figura si deve ricondurre a quella del “progettista” anche in funzione dell’incarico ricevuto e per aver espletato le prestazioni professionali prima viste, quali i sopralluoghi, i rilievi dell’immobile, la rappresentazione grafica, nonché la comparazione tra lo stato di fatto e gli atti assentiti, l’analisi delle difformità e l’individuazione del regime edilizio nel quale rientrano e mediante il quale regolarizzarle.
2) Il ruolo del tecnico - progettista
Il tecnico è il professionista che, iscritto nel relativo albo, presta opera intellettuale la cui disciplina è regolata dal Codice Civile, artt. 2229 – 2238 e dal Codice Deontologico dell’Ordine Professionale di appartenenza.
La prestazione professionale si incentra su determinati principi tra i quali annoverare il rapporto di fiducia con il committente in stretta concomitanza con l’autonomia del tecnico nell’espletamento del mandato, ed in capo al quale deve corrispondere un adeguato compenso commisurato sia all’importanza dell’opera e sia al decoro della professione svolta.
Per quanto concerne la progettazione è noto essa consista nell’elaborare un progetto da non configurarsi nel senso stretto dei soli grafici, bensì in tutte le operazioni che ne permettono la redazione, progetto che naturalmente non può non essere redatto nel rispetto della disciplina urbanistico – edilizia e di ulteriore altra legislazione settoriale se l’immobile è assoggettato a vincolo, previa l’implicita e sempre dovuta osservanza dello Strumento Urbanistico, del Regolamento Edilizio Comunale, delle normative igienico – sanitarie, delle norme sulla prestazione energetica degli edifici e quanto altro necessario.
È durante le fasi di rilievo dell’edificio che il professionista acquisisce tutte le nozioni necessarie per concretizzane la successiva rappresentazione grafica, assume sin da quel momento il ruolo di esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art.481 del Codice Penale. Inutile precisare lo stato di fatto dell’edificio, per norma e prassi, costituisca parte integrante e sostanziale di un progetto destinato al deposito in comune, dovendo corrispondere fedelmente ai luoghi, prevalendo su eventuali progetti precedenti, ragion per cui è consuetudine corredarlo della documentazione fotografica, relazione tecnica ed elaborati tecnici che, rispettivamente integrandosi, debbono fornire una corretta rappresentazione del manufatto edilizio.
Detto ciò emerge che l'errata rappresentazione formi ’illegittimità del titolo edilizio legandosi inscindibilmente alle dichiarazioni rese dal tecnico.
Il nesso logico di particolare riferimento riguarda il fattore la prestazione professionale prescinda, ragionevolmente, da ogni genere di richiesta del committente laddove essa non risultasse allineata con le disposizioni normative e regolamentari secondo un ordine gerarchico assolutamente superiore.
Onere del tecnico è mantenere inalterata l’integrità professionale quandanche il cliente si focalizzi ostinatamente al raggiungimento di un suo specifico scopo o di un interesse economico, nell'intento di realizzare interventi edilizi seppur venendo meno all'osservanza della norma, ovvero ignorando la presenza di un abuso edilizio, circostanza nella quale il ruolo del professionista deve coincidere con quello di garante anche tenuto conto delle conseguenze, comprese quelle di natura penale, non efficaci nei suoi soli confronti ma, bensì, anche nei confronti della committenza.
Entrando nel merito dei contenuti del d.P.R. 380/2001, l’art.29 “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” è al comma 3 ad essere reso oltremododo chiaro il concetto secondo cui la figura del progettista debba assorbirsi a colui che esercita un servizio di pubblica utilità. Ampia conferma si riscontra nella dichiarazione resa dal tecnico sotto forma di asseverazione nei titoli abilitativi edilizi: ”Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico […]”.
Giuridicamente inteso debbano far capo al tecnico obblighi e responsabilità rilevanti rispetto a quelli di carattere generico, le cui conseguenze, per il venir meno, operano sia sul profilo civile, che su quello penale, a prescindere dal fattore la fase progettuale sia stata formalizzata con il solo conferimento dell’incarico professionale, ma non conclusasi con la presentazione del progetto all’ente preposto.
Al professionista che, in carenza dei requisiti e dei presupposti fondamentali, inoltra un progetto agli enti è ascrivile il reato di cui all’art.481 del Codice Penale “Delitto contro la fede pubblica” punito per falso ideologico commesso dall’esercente un servizio di pubblica utilità, ciò assume rilievo anche nella pronuncia della Corte di Cassazione Penale con la Sentenza 27699/2010: “Il progettista assuma la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate”.
La sentenza 27699/2010 definisce esaustivamente la circostanza nella quale il progettista, ignorando le verifiche obbligatorie, attesti falsamente, trasmettendo il progetto al Comune, casistica comportante, a sua volta, l’onere per l’amministrazione comunale, chiaramente in quei pochi casi nei quali rilevato l’”errore”, di dover denunciare le irregolarità commesse dal tecnico al Consiglio di Disciplina dell’Ordine Professionale ove iscritto per le eventuali sanzioni disciplinari
3) La prassi corretta laddove il committente crei insistenze per il completamento della prestazione professionale
La abbiamo trattata sinora, la stessa deve, naturalmente, concludersi con la risoluzione del mandato professionale, per tutti i motivi citati, considerando la responsabilità dei soggetti implicati in un processo edilizio (proprietario, progettista, direttore dei lavori) laddove siano iniziati i lavori, maturi immediatamente nel momento in cui realizzate opere in difformità rispetto al titolo, così come nel caso in cui un intervento sia assoggettato al regime della richiesta del permesso di costruire ma venga trasmesso un titolo abilitativo edilizio minore, così come nel caso in cui si intervenga in un edificio nel quale presenti difformità, maturando in questi casi, e come prima citato, il reato di cui all’art.481 del Codice Penale, come conferma la Corte di Cassazione Penale con la Sentenza 30401/2009.
4) Trattazione di un caso pratico: “il committente si rivale sul tecnico – progettista per non aver inteso presentare progetto di ristrutturazione per l’immobile nel quale presenti abusi edilizi”
Siamo giunti in un periodo nel quale non escludere l’ipotesi del committente che, mirando esclusivamente alla fruizione delle agevolazioni fiscali in edilizia, in particolare il cd. “Superbonus 110%” e delle opzioni alternative alla detrazione, quali lo sconto in fattura e/o la cessione del credito, fin tanto che furono vigenti, sia egli medesimo d’ostacolo per il corretto adempimento del mandato professionale del tecnico incaricato.
Poniamo la circostanza nella quale il professionista, ricevuto l’incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità degli interventi oggetto di detrazioni, nonché la progettazione e la successiva direzione lavori, nonostante la semplificazione introdotta al comma 13-ter dell’art.119 del decreto Rilancio, non più comportante l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, stabilisca di operare secondo diligenza, ragion per cui si “cimenta” all’analisi di tutta la documentazione edilizia in possesso del cliente e depositata presso gli enti, effettua gli opportuni accertamenti, rilievi e misurazioni in sito e ricava l’edificio non sia conforme né rispetto ad una Autorizzazione Edilizia ottenuta anni prima e né rispetto ad una successiva S.C.I.A. Oltremodo il professionista incaricato analizzando i citati titoli edilizi precedenti ravvisa siano carenti, il primo, della comunicazione del termine dei lavori, ed il secondo del collaudo amministrativo, deducendone le risultanze normative.
Portato il committente a conoscenza della questione lo ragguaglia, come abbiamo accennato al paragrafo 1, circa la necessità di trasmettere, preventivamente alla pratica edilizia per l’avvio dei lavori agevolati, il progetto finalizzato alla regolarizzazione degli abusi, facendo, altresì, presente che in caso contrario pena la rinuncia all’incarico professionale per impossibilità a procedere.
Come trattato nel presente il committente è la figura che affidandosi al professionista, secondo un rapporto di fiducia, deve pretendere questo agisca secondo scienza e coscienza con il dovere dell’osservanza di ogni principio etico, deontologico ed operativo legato allo svolgimento della sua professione, fattore sul quale il committente non sempre conviene.
Alla luce di ciò, sovente la committenza richiede altri pareri e nel rivolgersi ad un altro professionista, purtroppo, non solo riesce a raggiungere il suo scopo venendo meno ad ogni logica legislativa, inconsapevole di ogni possibile problematica futura soprattutto se derivante dai controlli da parte del fisco inerenti la indebita fruizione delle agevolazioni fiscali, ma più gravemente la committenza in questione viene diretta verso una concezione non legittima sotto nessun profilo.
Non sono casi, purtroppo rari, anzi con più costanza si verifica il privato riesca ad individuare un tecnico che, senza effettuazione di alcuna verifica in senso alla legittimità urbanistico – edilizia del manufatto edilizio, così come dal punto di vista strutturale ed antisismico, asseveri facilmente i futuri interventi da realizzare, conducendo il soggetto titolare non solo in una convinzione scorretta, ma ponendolo nella posizione dei rischi derivanti dall’illecito edilizio e dalle frodi fiscali.
Tornando al nostro esempio, la casistica in questione si conclude con l’azione del committente giungendo a denunciare il precedente tecnico per essersi, giustamente e legittimamente, rifiutato di rendere false attestazioni ed asseverazioni, pertanto di presentare un progetto.
L’accusa del committente nei confronti del professionista ha ad oggetto essere egli causa della perdita delle agevolazioni fiscali.
5) L’azione immediata del professionista
Chiaramente ciò che porta ad agire il tecnico è far luce sulla motivazione impeditiva del prosieguo del rapporto professionale, quindi sulla presenza degli abusi edilizi nel fabbricato, per fare ciò richiede agli enti preposti gli opportuni e dovuti accertamenti.
In relazione alla pendenza della denuncia elevata dal committente presso il Consiglio di Disciplina dell’Ordine Professionale nel quale iscritto il tecnico, è in sede di audizione di questi che, inopportunamente, l’organo giudicante eccepisce il venir meno del professionista al cd. “segreto professionale” con la richiesta di accertamento agli enti circa gli abusi edilizi, ciò nonostante letteratura, annotazioni e pronunce giurisprudenziali, nonché normativa e provvedimenti vigenti classifichino tale segreto professionale in tutt’altra sfera giuridica.
6) Il segreto professionale: oggetto e complemento
Il segreto professionale è giuridicamente definito un’“obbligo normativo per alcune figure professionali, quali il libero professionista, il lavoratore dipendente ed il dipendente pubblico, cui imposto non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali venuti a conoscenza per motivi di lavoro e soprattutto per le quali è imposto uno specifico obbligo di segretezza”.
Coincide con un vincolo di riservatezza ma attiene solo ed esclusivamente i dati sensibili conosciuti in relazione e durante l’attività svolta, nulla vi ha a che vedere e rileva ai suoi fini se costituente informazioni di pubblico dominio, rientrano tra queste tutte quelle inerenti un immobile, proprio per l’assenza del requisito di segretezza.
Come accennato oggetto dell’assoluto mantenimento del segreto professionale sono solo i dati sensibili, ovvero tutte le informazioni che, permettendo di identificare un soggetto, ne rivelano caratteristiche proprie, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute, patrimoniale, e così via, vi rientrano i dati anagrafici, le immagini, il codice fiscale, il numero di targa, ed ancora i dati svelanti l’origine razziale o etnica, la declinazione religiosa, ideologica.
Si annoverano tra i dati sensibili anche le comunicazioni telefoniche o avvenute a mezzo internet, la geolocalizzazione e tutte le informazioni che, in genere, rivelano gli spostamenti e/o i luoghi frequentati, inoltre il Regolamento UE 2016/679 include i dati genetici, i dati biometrici ed i dati afferenti l’orientamento sessuale.
Sono protetti da tutela del segreto professionale i dati “giudiziari” riguardanti le condanne penali ed i reati, le qualità di imputato o di indagato, e, come introdotti dal Regolamento UE sopra citato, i dati relativi alle condanne ed ai reati connessi con le misure di sicurezza.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per quanto concerne il trattamento dei dati personali del cliente, da parte del Titolare, il professionista, il riferimento specifico è ampiamente ricondotto all’indirizzo, al codice fiscale, e quanto previsto al punto 1, paragrafo 1, dell’articolo 4, spetta, pertanto, al Titolare del trattamento dei dati personali tutelare, con o senza mezzi automatizzati, esclusivamente ciò che riguarda la “protezione” dei dati sensibili, mediante la raccolta, la registrazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione e così via, come disposto dal punto 2, paragrafo 1, articolo 4 del Regolamento UE 2016/679.
A rigor di logica ed a scanso di ogni mera interpretazione secondo il dettato normativo ed il Codice Deontologico il professionista, nel non venir meno al segreto professionale, ha il dovere e l’obbligo di mantenere la massima riservatezza sull’attività prestata, sulle informazioni fornite dal cliente e su quelle di cui venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, obbligo permanente anche a conclusione del mandato professionale con valenza per i suoi dipendenti o collaboratori, rispondendone egli per l’eventuale infrazione da parte di questi ultimi.
Obbligo che chiaramente e senza dubbio attiene i dati sensibili come elencati e non fattori o elementi inconducenti derivanti da soggettive interpretazioni che ne viziano il legittimo raggio di applicazione.
7) Il segreto professionale al cospetto di ciò che attiene un immobile
Già precisato, non esiste attinenza alcuna tra quanto rientrante nel criteri del segreto professionale rispetto ai dati di un immobile, avvalorando la tesi, non l’ipotesi, l’azione del professionista consista, tra le varie, anche in un indiscusso dovere di tutelare l’interesse collettivo salvaguardato con la repressione dell’abusivismo edilizio.
La segnalazione di un illecito edilizio conforma, oltremodo, un rapporto di concomitanza dovuto al fattore rientri l’abuso tra i reati, ragion per cui ai sensi della normativa è “imposto” al professionista, nel ruolo da egli svolto, di denunciare l’illecito di cui si è venuti a conoscenza, sia per disposto del Codice Penale e sia nella veste del pubblico ufficiale che omettendo o ritardando la segnalazione all’autorità commette ulteriore illegittimità con prevista punizione.
Rientra nella medesima fattispecie la circostanza nella quale il professionista assolva al dovere anche nel corso di una controversia con un cliente, ovvero nel contesto di una procedura disciplinare, limitatamente al necessario o più ampiamente rispetto al fine da salvaguardare.
8) La Fondazione Italiana del Notariato
L’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, ha diffuso il trattato “Il segreto professionale. La tutela del segnalante. Il divieto di comunicazione. La tutela della privacy” di Caterina Valia, dal trattato emerge in relazione al segreto professionale: “Il concetto di giusta causa consente di tracciare i limiti di operatività del segreto professionale giustificando la rivelazione della notizia ed esonerando il professionista da qualunque responsabilità; è necessario effettuare, quindi, un'attenta valutazione dei vari interessi coinvolti di volta in volta e, operando un bilanciamento tra le contrapposte esigenze, sacrificare la segretezza nelle ipotesi in cui sia necessario garantire l'attuazione di prevalenti finalità”.
Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita